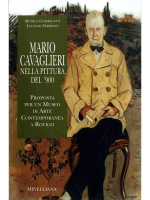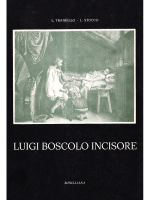Risorgimento italiano e canto sono due concetti che spontaneamente si accoppiano nella mente di tutti, e rimandano alle manifestazioni di patriottismo suscitate dalle rappresentazioni delle opere verdiane del primo periodo, fino a « La battaglia di Legnano ». Il Biscaccia ricorda come anche a Rovigo gli austriaci temessero le conseguenze sull’animo del pubblico di certi passi dei melodrammi di Verdi: nel 1856 i rodigini vollero festeggiare l’imperatore, in visita alla città, con la rappresentazione (evidentemente intenzionale) del « Nabucco »: Francesco Giuseppe non poté sottrarsi al dovere di presenziare allo spettacolo, ma dopo il secondo atto, prima che si cantasse « Va pensiero sull’ali dorate », aveva abbandonato il Teatro Sociale.
Anche Rossini, Bellini, Mercadante, Donizetti, avevano offerto pretesti a manifestazioni di patriottismo da parte del pubblico; ma con Verdi fu un’altra cosa. Non si trattò solo, come suggerisce Carlo Gatti, di tempi più maturi (« Verdi », Milano, 1951, p. 162), ma di una effettiva diversità di linguaggio: Verdi, più d’ogni altro, si rivolse – almeno fino a « La traviata » compresa — ad un pubblico che è popolo. E il popolo rispose in modo entusiastico al richiamo di quelle melodie.
Ma non si può spiegare la singolare fortuna del melodramma in Italia nel secolo scorso unicamente con la presenza di un genio creatore di un linguaggio tanto universale da essere anche popolare, o con la strumentalizzazione in chiave patriottica delle opere d’arte: anche la poesia, per esempio, ebbe un genio affatto paragonabile a Verdi – e fu Manzoni – ma non riuscì a calamitare le emozioni delle masse. Il fatto è che l’Italia (a differenza della Germania, dove la diffusione della cultura era sufficiente- mente avanzata, sì che i suoi poeti e i suoi drammaturghi poterono essere ascoltati dal popolo) era mantenuta in una drammatica condizione di ignoranza: a quel livello il linguaggio poetico – anche quello manzoniano – restava non solo difficilmente avvicinabile, ma anche troppo astratto, mentre il canto, implicando una partecipazione fisica dell’esecutore – partecipazione a cui è affidata l’espressività — poteva trovare in un popolo analfabeta una possibilità se non di comprensione estetica, di consonanza emotiva.
Quanto a Verdi, la sua particolare fortuna trova una spiegazione proprio in questo senso. « Nessun dubbio – ha scritto Massimo Mila – che la ispirazione di Verdi sia essenzialmente melodica, nel senso più italiano della parola; la voce umana è il medium dei suoi pensieri musicali, presentati sempre sotto forma di una lineare e singola melodia » (« Il melodramma di Verdi », Milano, 1960, p. 109); e ne è una riprova il distacco che si è creato con il pubblico quando, dopo « La traviata », la sua ispirazione, pur rimanendo intimamente la stessa, s: è andata arricchendo sul piano culturale con l’« adozione di una tecnica più ricca e complessa » (Mila) fino a culminare nell’ultimo capolavoro, « Falstaff », tanto grande quanto poco amato dalla folla.
L’analisi del rapporto fra melodramma e pubblico nell’Italia dell’Ottocento sarebbe rivelatore di molti spunti per comprendere il nostro Risorgimento, anche e specialmente per quel tanto di eroico che effettivamente ebbe e che per la storiografia liberale (e per le sue stanche derivazioni che ancor oggi non si sono spente) rimase l’aspetto più appariscente. Perché Rossini non fu mai veramente popolare, perché cominciò ad esserlo Donizetti, perché poi Verdi toccò un vertice di popolarità che vive tuttora, e che non ha paragoni in altro musicista, può intuirsi esaminando l’evoluzione dello stile di canto in questi compositori; e un simile esame fa capire perché il wagnerismo avviò la fine del melodramma italiano dopo Verdi (con la sola eccezione di Puccini). E così sarebbe altrettanto istruttivo lo studio delle varianti apportate ai testi originali dai cantanti (i quali, sintomaticamente, erano i veri protagonisti del melodramma), che ben sapevano in qual modo accattivarsi le simpatie di un pubblico che nulla capiva di ragioni stilistiche o espressive, ma rimaneva inebriato dalla sensazione fisica della nota acuta realizzata da una voce ben timbrata e potente (come oggi, del resto, i cosiddetti « urlatori » della musica « leggera » sanno ben catturare i favori – e i portafogli – di un pubblico culturalmente povero, in caccia di sensazioni fisiche).
Ma uno studio del genere, sebbene qui non del tutto fuori luogo, ci porterebbe troppo lontano: basti l’avervi accennato. Ciò, comunque, è già sufficiente per sottolineare due aspetti della questione: l’importanza dell’elemento « popolo » nel periodo romantico e, in particolare, in Italia, nel periodo risorgimentale; e come fosse il canto l’unico ed efficace veicolo di diffusione fra le masse del sentimento di essere « popolo italiano ».
Chi ha studiato il nostro Risorgimento oltre che sui libri di scuola, anche su testi di autori ottocenteschi quali il Cattaneo, il Ferrari, la Bel- giojoso, il Pisacane (per citare qualche nome alla rinfusa), ne avrà ricavato un’esaltante impressione di coralità, quasi che tutti gli italiani – senza altra distinzione che non sia dagli austriacanti, presentati come traditori — covassero nel cuore il fuoco ardente dell’amor di patria.
Quella parte (che dovette essere notevole) di popolazione che rimase indifferente o estranea o, comunque, al di fuori dello spirito del Risorgimento – e che ci è così vivamente rappresentata in romanzi come « Il mulino del Po » o « Il Gattopardo » – sembra non esistere per gli autori di un secolo fa. E, trascinati dal loro entusiasmo, non ci accorgiamo che i Mille di Garibaldi erano « soltanto » mille, e che coloro che manifestavano per l’Italia unita e indipendente alle rappresentazioni del « Nabucco » o dell’« Emani » erano, al massimo, le migliaia che potevano essere contenute nei teatri, contro le centinaia di migliaia che rimanevano fuori a pensare ad altro. E ci dimentichiamo dei trucchi elettorali senza i quali le plebiscitarie richieste di annessione al Piemonte avrebbero potuto avere èsiti meno convincenti. Anche oggi, malgrado la vittoriosa lotta contro lo analfabetismo, malgrado la meravigliosa fioritura di strumenti di facile comunicazione delle notizie e delle idee, succede che gran parte della popolazione si lasci semplicemente trascinare da alcuni gruppi veramente attivilo addirittura che rimanga estranea a vicende che pur dovrebbero interessare tutti da vicino: quanto più doveva accadere nell’Italia del XIX secolo, faticosamente alla ricerca di se stessa!
Eppure, è proprio nella « finzione » letteraria o artistica degli autori ottocenteschi che si gettano le basi della nuova società italiana: le astratte speculazioni degli illuministi di un secolo prima, acquistano corpo e sostanza nel periodo romantico, creatore del concetto di « popolo » con il significato moderno di una società di uomini uguali per dignità e destino, indipendentemente dalle condizioni di origine. Il primo, grande romanzo europeo, « I promessi sposi», ha per protagonisti due contadini veri.
Gli artisti, ancóra una volta, avevano intuito qualcosa di più che i politici, e le loro opere contribuirono in modo considerevole a diffondere le nuove concezioni, fra cui, fondamentale, quella di « nazione » (o di « patria »). Federico Chabod sintetizzò felicemente questo nuovo concetto che si affacciava alla storia d’Italia, contrapponendo due esponenti tipici di due culture – l’una ancorata al passato, l’altra proiettata nel futuro — presenti in Europa nello stesso periodo: Metternich e Mazzini. « Tipicamente settecentesco nelle origini del suo pensiero e politicamente fermo su posizioni di conservazione pura, cioè su posizioni reazionarie, Metternich rifiuta di accettare la nazione, la patria, così come rifiuta di accettare l’idea di libertà: queste due potenti forze spirituali, che l’età della Rivoluzione francese ha lanciato nel mondo, Metternich non solo le ignora, ma anzi le vuole combattere ». All’opposto « Mazzini, che esalta tanto la nazione, la patria, pone tuttavia la nazione in connessione strettissima con l’umanità. La nazione non solamente non è fine a se stessa, ma è mezzo necessario e nobilissimo, per il compimento del fine supremo, e vale a dire l’umanità. ‘La patria è il punto d’appoggio della leva che si libra tra l’individuo e l’Umanità’» («Storia dell’idea di Europa», Bari, 1964, pp. 132-133).
Se per storia si intende l’indagine dello sviluppo della civiltà umana e non la descrizione delle battaglie o la ricostruzione delle manovre politiche (che della civiltà sono semplicemente alcuni degli innumerevoli strumenti per mezzo dei quali essa si realizza), è legittimo o, forse, addirittura necessario domandarsi, a proposito del Risorgimento, come reagiva il popolo alle diverse sollecitazioni esterne che lo spingevano ad acquisire una coscienza di sé mai avuta prima d’allora (se non, forse, ma in modo totalmente diverso, agli inizii della diffusione del cristianesimo) e che esigeva di fare del popolo stesso il nuovo protagonista della storia. Da qui la necessità di indagare le diverse manifestazioni popolari, fra le quali il canto era certamente la più congeniale ai contadini e agli operai che – analfabeti — volevano esprimere le loro passioni.
Si comprende, ora, il valore dell’opera di Antonio Cornoldi che con tenace pazienza e scrupolosità inesausta ha realizzato uno studio sugli avvenimenti risorgimentali visti attraverso i canti popolari che è riuscito ancóra a raccogliere in Polesine; studio che fa séguito all’altro, più ponderoso, su « Ande, bali e caute del Veneto ».
L’esiguità di questo « Avvenimenti risorgimentali attraverso i canti popolari del Polesine » non deve far credere ad una sua scarsa significatività: se quantitativamente il materiale raccolto non è molto, esso è tuttavia chiaramente indicativo, perché l’animo popolare non conosce individualismi, e la collettività si esprime anche attraverso il canto di uno solo. Il lavoro dello studioso polesano, quindi, ci consente di seguire in modo esplicito la nascita e l’evoluzione di un pensiero: l’istinto di ribellione alle sopruserie che contro gli eserciti invasori — francesi o austriaci — era più volte esploso apertamente, quando passa ad avere a che fare con la polizia asburgica deve essere dominato, ma non può essere soffocato. Da qui uno scontento che i patrioti coltivano nell’animo popolare, e sul quale fanno leva per diffondere l’idea di patria. Le prime espressioni antiaustriache di schietta origine popolare che il Cornoldi è riuscito a documentarci, riguardano il nu-mero dei pasti: è una semplice strofa di protesta dal contenuto chiaramente banale. Ma gradatamente il popolo elabora determinati concetti, passando ad invettive contro i croati (passando, cioè, ad un primo stadio attivo), per arrivare, alla fine, ad accogliere canti ed inni di origine colta senza neppure avere più bisogno di modificare o addirittura di parodiare il testo.
E qui è facile immaginare il peso avuto, in quest’evoluzione, dai patrioti — spesso persone di origine nobile e, comunque, colte — che con ardente passione non mancavano di divulgare l’idea di indipendenza nazionale, ben consci del fatto che la nostra soggezione agli altri stati di Europa dipendeva dall’essere, noi, « un volgo disperso che nome non ha ». Mutati i tempi, acquisita, da parte del popolo, una coscienza di sé, quell’atteggiamento dell ‘élite culturale sarebbe diventato paternalismo; ma allora poté essere una prima, autentica scuola di democrazia.
L’opera di Antonio Cornoldi, dunque, ci offre – direttamente e indirettamente – notevoli spunti per ripensare la nostra storia recente secondo un angolo visuale non inedito, è vero, ma certamente non usuale: e questo ci consentirà di comprendere meglio il senso dell’epoca in cui viviamo, e che in Italia ebbe origine con le vicende del Risorgimento.
Leobaldo Traniello