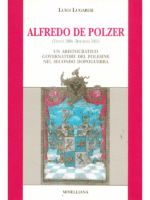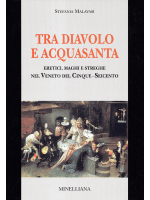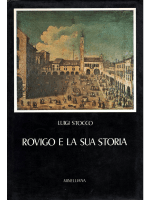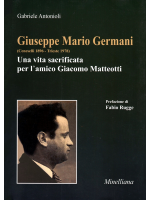Dal passato – si potrebbe quasi dire in articulo mortis ! – mi giunge la buona notizia che l’associazione culturale-Editrice Minelliana pubblica come volume quella che fu un quinquennio fa la tesi di laurea di Davide Dal Bosco e, insieme, anche la richiesta di questa prefazione.
La nota luttuosa congenita alla nascita non si riferisce tanto alla mia intanto sopraggiunta fine accademica, quanto invece alla fine dell’Università che non solo rendeva possibili, ma idealmente anche richiedeva e spingeva studenti e docenti a fare tesi di ricerca, a lavorare sodo e cogliere, per esempio, l’occasione della laurea per impegnarsi in un lavoro di scavo socialmente utile.
Non solo gli aspiranti ricercatori – il nostro ipotetico ricambio nell’insegnamento universitario -, ma tutti i laureandi.
Questo, per lo meno, il dover essere, che abbastanza spesso diventava un essere.
Adesso – dopo la distruttiva ‘riforma’ – il ‘dover essere’, posto che ce ne sia uno chiaro e distinto, non è certo questo.
Sarei infelicissimo, se fossi ancora in servizio, mancandomi il seminario settimanale in cui crescevano a contatto di gomito, non solo con il docente, ma fra di loro, i miei laureandi.
Verrebbe considerato dai più un eccesso di zelo, un intralcio alla anonima catena di montaggio e al moderno fare in fretta.
Davide Dal Bosco, di cui sin qui mi sono servito come occasione a una rabbiosa lode, nonostante tutto, dell’università di una volta – mica tanto tempo fa, diciamo prima della riforma di Berlinguer (il ministro, non quello ‘vero’) e di Gelmini – era già sul limite fra le due stagioni.
Lo ricordo come uno spirito indipendente e volitivo: si è, in larga misura, ‘fatto da sé’.
Avevamo individuato – fondamentale punto di partenza – un tema motivato e motivante, a suo modo un gran bel personaggio, per più versi emblematico, da ricostruire biograficamente e da approfondire calandolo nel contesto polesano di cui è frutto ed attore, non minore: Pino Bellinetti un giornalista in camicia nera.
E che bello, una volta tanto, lavorare su un militante fascista non pentito e non intento a nascondere le tracce della sua vita precedente.
Non ho mai avuto l’impressione che Dal Bosco avesse, nel farne il suo personaggio, le stesse e tutte intere le ragioni che potevano portare me a riconoscervi un allettante prototipo di intellettuale fascista ‘diffuso’, punto di incrocio fra intellettuali militanti e intellettuali funzionari.
Ma ci incontravamo e convergevamo senza fatica, perché a lui primariamente interessava studiare un bel pezzo di storia polesana attraverso una biografia idonea a condurci, stando all’avanguardia dei processi, materiali e mentali.
Vaghi precedenti ambientali ‘socialisti’, in famiglia e nel Polesine di fine Ottocento, da cui procedere e scindersi; futurismo, nazionalismo, interventismo; guerra e dopoguerra usati, anche, per essere e sentirsi giovani e per diventare – diversamente – adulti; come affermarsi e, se possibile, uscire dall’odiosamata provincia; oppure anche diventarne i rissosi e esigenti portavoce, ritrovando anche così un ruolo proprio, fra dentro e fuori, sempre sentendosi un polemico uomo di confine.
E tutto questo, da squadristi, da rivoluzionari della terza via, né capitalista né bolscevica; e – valore aggiunto, dono della complessa e nazionalmente significativa geografia politica del territorio – nella provincia di Giacomo Matteotti, il nemico pubblico n. 1 del fascismo; che è però anche l’area di influenza dei Marinelli, dei Finzi, dei Casalini, dentro ai cui potentati destreggiarsi, come Pino Bellinetti si industria di fare, con alterna fortuna. E sempre seguito con scrupolo documentario e curiosità intellettuale, dall’autore.
Il secondo e terzo capitolo – 150 pagine, quelle centrali – rendono protagonista il primo dopoguerra, lo squadrismo, le lotte per il potere, con riposizionamenti convulsi e itinerari aggrovigliati.
Dal Bosco scrive chiaro, governa opportunamente i materiali, di natura archivistica e soprattutto – trattandosi poi di un giornalista e di un aspirante narratore – di natura pubblicistica.
Molti rari testi di dimenticati quotidiani e giornaletti ci vengono così messi a disposizione, e non è l’ultimo pregio del lavoro, che è anche uno spaccato di storia locale, Rovigo fascista.
Il quarto capitolo tematizza la questione Matteotti e non ci si può aspettare che l’approccio all’“onorevole milionario” – è il meno peggio fra le molte cose ostili che Bellinetti dice di questo rinnegato della propria classe – sia analogo a tutti quelli che ne fanno una dolorante vittima di soprusi inconsulti.
Qui infatti la violenza non è il male, è la quintessenza della lotta politica giunta là dove l’arco maggiormente si tende; siamo negli anni in cui Mussolini stesso ripropone Machiavelli come maestro di dottrina e persino a scuola si impara quel che accade a Vitellozzo Vitelli e ai suoi pari, quando si mettano sulla strada del Duca Valentino.
Fra le due guerre, le vicissitudini del giornalista della “Voce del Mattino” forniscono informazioni e suggeriscono riflessioni sul diverso concetto della stampa attuato e teorizzato, sia dal Ministero della cultura Popolare che dai pratici e teorici del giornalismo: è una milizia politica, al servizio del Partito che si è fatto stato.
E una conseguenza è che anche gli intellettuali militanti si facciano essi stessi diligentemente funzionari, magari pure con penna pugnace.
Bellinetti forse fatica più di altri, scalpita un po’, gli viene meno naturale che fare l’avanguardia movimentista, ma i tempi sono mutati.
La Repubblica Sociale sembra potergli riaprire spazi più personali di interpretazione e di intervento.
Bellinetti è tornato nel Veneto, lo mandano a dirigere il quotidiano di Padova, il vecchio foglio della borghesia radical-progressista, da cui le leggi razziste hanno poco prima costretto a sloggiare il proprietario.
Si esalta, capisce male, fraintende il senso della c.d. ‘socializzazione’, suppone che sia tornato il momento in cui si balla di nuovo al confine fra i mondi contrapposti, ‘al di là’ della destra, al di là della sinistra. Socialismo nazionale? Gli fanno subito capire che non è cosa. Non si tratta di socialismo. E lo sostituiscono.
In qualche modo, nascondendosi al momento buono, riesce a non farsi prendere dai partigiani, sfugge a vendette e ritorsioni.
E, nel secondo dopoguerra, rientra in qualche modo in carriera, non però alla grande, come altri fascistoni, più propensi a incarnare figure e linguaggi d’ordine.
Cerca di fare qualche cosa di più che sopravvivere, fa anche qualche buon colpo giornalistico, nel nome della gioventù e del succedersi delle generazioni prova persino a gigioneggiare e flirtare con il ‘68; ma le sue stagioni migliori appartengono ormai al passato.
Finale in dissolvenza, per la sua vita e per la tesi. Muore nel 1969, a 74 anni.
Mario Isnenghi